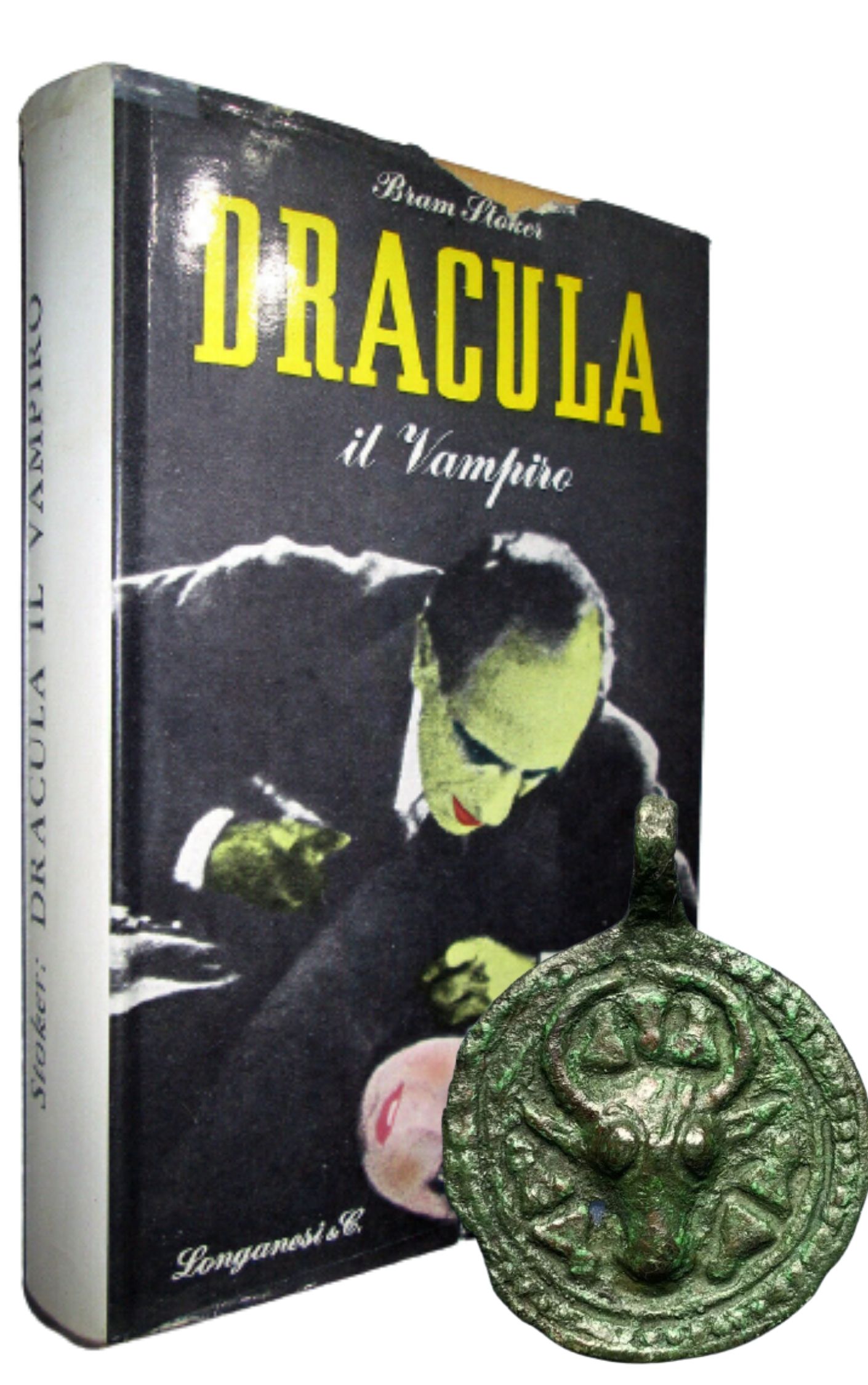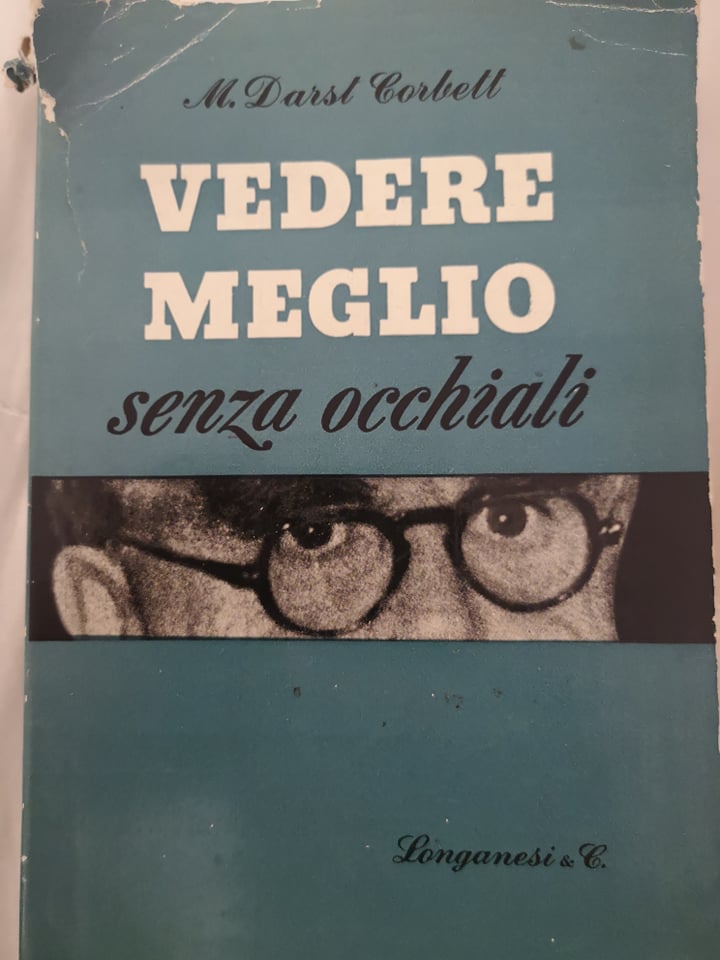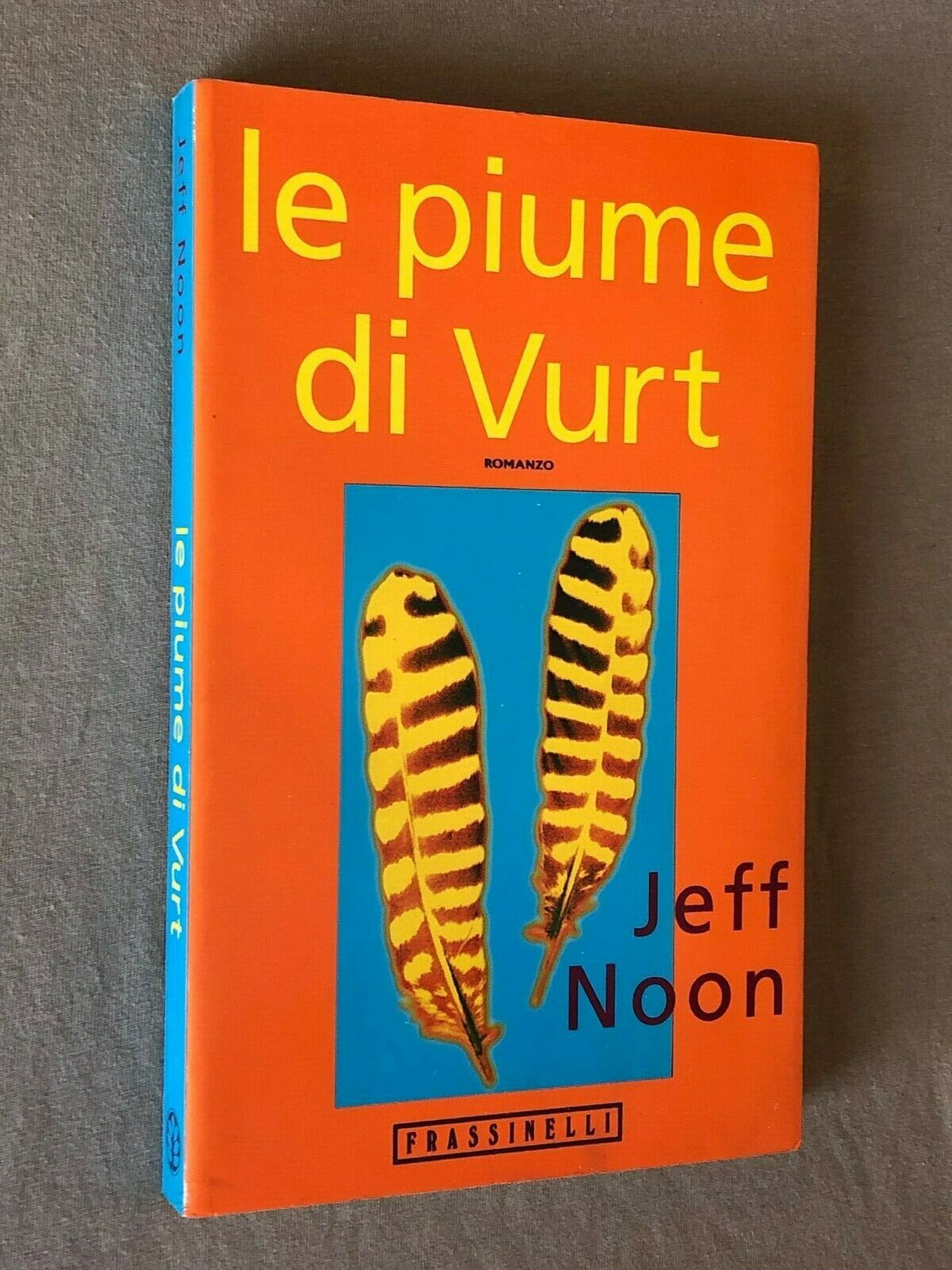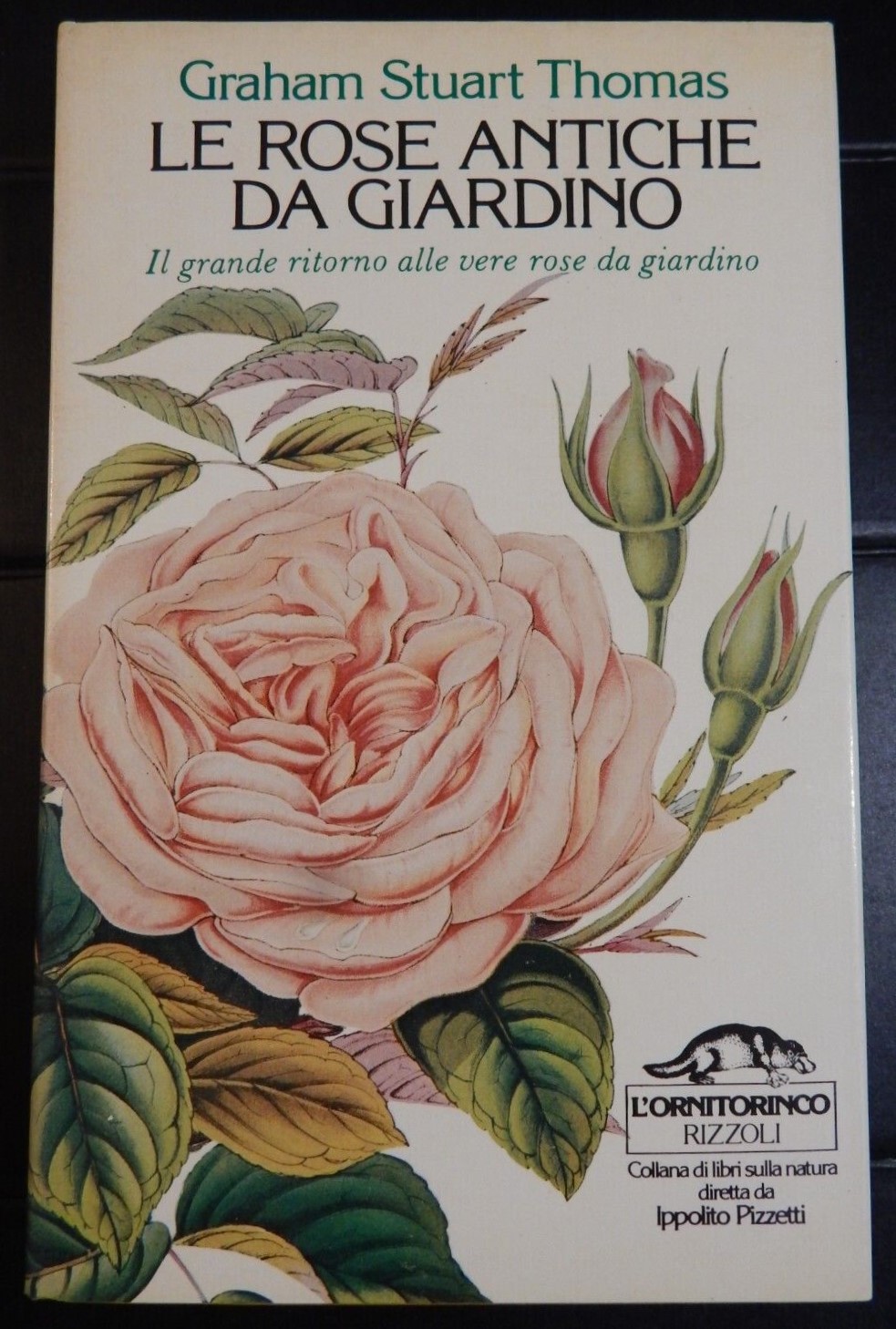Francesco Mastriani: il romanziere del popolo napoletano
Francesco Mastriani (Napoli, 1819-1891) rappresenta una delle figure più significative e prolifiche del panorama letterario italiano ottocentesco, benché la sua fama sia rimasta confinata prevalentemente in ambito locale. Autore di oltre cento romanzi d’appendice, Mastriani si distinse per la sua straordinaria capacità di raccontare le classi popolari napoletane, mescolando elementi gotici, sociali e di cronaca nera in narrazioni avvincenti che catturavano l’attenzione di un vasto pubblico di lettori. La sua opera costituisce un prezioso documento storico-sociale della Napoli ottocentesca e ha contribuito significativamente sia alla nascita del meridionalismo che allo sviluppo del verismo italiano. Particolarmente interessante è la vicenda editoriale del suo romanzo d’esordio, “Sotto altro cielo“, la cui prima edizione risulta misteriosamente introvabile, alimentando interrogativi sulla possibile autocensura dell’autore in un periodo politicamente complesso della storia napoletana.
Francesco Mastriani nacque a Napoli il 23 novembre 1819 in una famiglia borghese agiata, figlio di Filippo Mastriani e Teresa Cava. Terzo di sette figli che Teresa diede a Filippo, Francesco crebbe in un ambiente che, seppur benestante, lo metteva a contatto con la complessa realtà sociale napoletana dell’epoca. La sua formazione letteraria fu particolarmente ricca e variegata: già dal 1825 frequentò l’istituto di don Raffaele Farina, dove ebbe accesso a una vasta biblioteca. Nel 1835, appena sedicenne, Mastriani aveva già letto l’intera collezione di classici del suo maestro, composta da ben 400 volumi, dimostrando una voracità intellettuale notevolissima. Tra le sue letture si annoveravano opere di autori francesi come Jean-Jacques Rousseau e François-René de Chateaubriand, ma anche i classici italiani come Dante e le tragedie di Shakespeare, formando così un bagaglio culturale eclettico che avrebbe influenzato profondamente la sua produzione letteraria.
Nel 1836, a seguito della morte della madre, Mastriani fu costretto per volere paterno a impiegarsi presso la “Società Industriale Partenopea“. Questo primo contatto con il mondo del lavoro rappresentò un’importante esperienza formativa che gli permise di osservare da vicino le dinamiche sociali ed economiche della città. La sua formazione intellettuale fu influenzata da importanti figure del panorama culturale napoletano dell’epoca, tra cui Basilio Puoti, Francesco De Sanctis e Saverio Costantino Amato, per il quale nutriva particolare ammirazione e affetto. Questi incontri e le letture giovanili contribuirono a plasmare la sensibilità sociale e letteraria di Mastriani, orientandolo verso un’attenzione particolare per le classi subalterne e per le problematiche sociali della sua città, elementi che sarebbero diventati centrali nella sua produzione letteraria. La Napoli ottocentesca, con i suoi contrasti sociali e le sue contraddizioni, divenne così non solo lo sfondo, ma quasi la protagonista assoluta delle sue opere narrative.
Autore di oltre cento romanzi
L’autore napoletano fu incredibilmente prolifico, con una produzione che conta oltre cento romanzi pubblicati nell’arco di cinquant’anni di ininterrotta attività letteraria. La sua attività di scrittore si affiancò a quelle di drammaturgo e giornalista, rendendo la sua figura un punto di riferimento nella cultura napoletana del XIX secolo. Tra le sue opere più celebri si annoverano “La cieca di Sorrento” (1852), uno dei suoi primi successi, “I misteri di Napoli” (1869), forse il suo capolavoro, “I vermi” (1862-64), e “La sepolta viva” (1877). A queste si aggiungono altri titoli significativi come “Il mio cadavere” (1852), considerato dai critici il primo romanzo giallo-noir italiano, “La comare di Borgo Loreto” (1854) e “La spia” (1880). Questa vasta produzione, in gran parte pubblicata inizialmente a puntate sui periodici dell’epoca, secondo la formula del romanzo d’appendice, gli valse una notevole popolarità presso il pubblico napoletano e non solo, facendolo diventare uno degli autori più letti del suo tempo.
Particolarmente significativa nella produzione di Mastriani è quella che viene normalmente definita la “trilogia socialista“, composta dai romanzi “I vermi” (Stab. Tip. Gennaro Salvati, dopo il 1860), “Le ombre” (Stab. Tip. Gennaro Salvati, 1866?) e “I misteri di Napoli” (Stabilimento Tipografico del Commend. G. Nobile, 1869). In queste opere, l’autore affronta con maggiore profondità e consapevolezza le problematiche sociali della Napoli del suo tempo, descrivendo le condizioni miserabili in cui versavano i ceti popolari e denunciando le ingiustizie e le disuguaglianze della società post-unitaria. “I misteri di Napoli“, in particolare, rappresenta un affresco completo della società partenopea di metà Ottocento, in cui si intrecciano storie di miseria, criminalità, corruzione ma anche di riscatto sociale. Attraverso queste opere, Mastriani non solo intratteneva i suoi lettori con trame avvincenti e colpi di scena, ma contribuiva anche a sviluppare una coscienza sociale, gettando le basi per la nascita del meridionalismo e anticipando alcuni temi che sarebbero stati centrali nella successiva letteratura verista.
Lo stile narrativo di Francesco Mastriani si inserisce nella grande tradizione europea del romanzo d’appendice, traendo ispirazione soprattutto dai modelli francesi come Eugène Sue e Honoré de Balzac. Da Sue, autore de “I misteri di Parigi“, Mastriani riprese non solo il titolo per la sua opera maggiore, ma anche la tecnica narrativa basata sull’intreccio di molteplici storie e personaggi e sull’alternanza di scenari sociali diversi. Da Balzac, invece, derivò l’attenzione per il dettaglio realistico e la capacità di costruire personaggi complessi e psicologicamente credibili. La narrativa di Mastriani si nutre anche della tradizione gotica settecentesca, specialmente quella d’Oltremanica, incorporando elementi tipici del genere come atmosfere cupe, situazioni inquietanti e personaggi tormentati. Questa fusione di influenze diverse diede vita a uno stile personale e riconoscibile, che sapeva coniugare l’intento di denuncia sociale con le esigenze di intrattenimento proprie del romanzo popolare.
I romanzi di Mastriani sono caratterizzati da una serie di temi ricorrenti che riflettono le preoccupazioni sociali e morali dell’autore. Centrale è l’attenzione per le classi subalterne napoletane, di cui descrive con partecipazione emotiva le condizioni di vita, le sofferenze e le speranze. Questa attenzione si traduce in una narrativa che, pur non avendo un esplicito spessore politico (si è parlato per lui di un generico “socialismo cristiano“), ha un forte impatto di denuncia sociale. Altri temi ricorrenti sono gli amori proibiti, i misteri familiari, le vendette, i crimini efferati e le punizioni divine o umane. Dal punto di vista stilistico, Mastriani privilegia una prosa ricca e a tratti enfatica, caratterizzata da descrizioni dettagliate e da un uso sapiente del dialogo. La sua capacità di costruire trame complesse e avvincenti, ricche di colpi di scena e situazioni drammatiche, gli permise di conquistare un vasto pubblico di lettori, che Antonio Gramsci descrisse come “ingenui, fedeli e insaziabili”, affascinati dalla sua abilità di “far inorridire e lacrimare”.
Un aspetto particolarmente interessante della narrativa di Mastriani è la compresenza di elementi gotici e di un’attenta osservazione della realtà sociale. Nei suoi romanzi si trovano frequentemente situazioni estreme e inquietanti: torture, stupri, maledizioni, patimenti e orrori vari che attingono alla tradizione del romanzo gotico e del feuilleton francese. Tuttavia, questi elementi sensazionalistici si inseriscono in un contesto realistico, quello della Napoli ottocentesca con le sue contraddizioni e i suoi problemi sociali. Mastriani aveva infatti la straordinaria capacità di mescolare fantasia e finzione con i fatti di cronaca nera che affollavano i giornali partenopei dell’epoca, creando storie che, pur nella loro dimensione fantastica e a tratti inverosimile, mantenevano un forte ancoraggio alla realtà quotidiana. Questa fusione di gotico e realismo sociale costituisce uno degli aspetti più originali e interessanti della sua produzione, che si pone a metà strada tra la letteratura d’intrattenimento e quella di denuncia, anticipando per certi versi alcune caratteristiche del naturalismo e del verismo.
Il caso di “Sotto altro cielo”
“Sotto altro cielo” rappresenta un caso particolarmente interessante nella bibliografia di Francesco Mastriani, non solo perché si tratta del suo romanzo d’esordio, ma anche e soprattutto per il mistero che circonda la sua prima edizione. Nonostante gli sforzi di studiosi, appassionati e degli stessi discendenti dell’autore (Emilio e Rosario Mastriani), questa prima edizione risulta a oggi introvabile nelle biblioteche e nelle collezioni private, tranne che in un esemplare recentemente procurato (vedi immagini).
- la prima edizione del 1847 rilegata
- il frontespizio
Nei cataloghi bibliografici si trova qualche labile traccia che daterebbe l’opera proprio al 1847, ma il figlio di Mastriani, Filippo, nei suoi “Cenni” sulla vita e le opere del padre, afferma che il romanzo fu ultimato nel novembre del 1848 e cita anche una recensione apparsa nel gennaio 1849 sulle pagine del periodico “Lucifero“. La discrepanza tra queste date ha generato confusione tra gli studiosi, ma è probabile che l’errore derivi da un catalogo della Libreria Gianini e Fiore di Torino, che nei primi mesi del 1851 indicava “Sotto altro cielo” come pubblicato a Napoli nel 1847 in due volumi nel formato in dodicesimo.
Le ipotesi sulla scomparsa dell’edizione originale
La questione più intrigante riguarda però il motivo per cui questa prima edizione sia diventata introvabile. Una delle ipotesi più accreditate è che lo stesso Mastriani abbia deciso di ritirare e far scomparire il libro. Le ragioni di questa scelta potrebbero essere legate al contesto storico-politico in cui l’opera fu pubblicata. Siamo infatti alla fine del 1848, un momento particolarmente turbolento per Napoli e per l’intero Regno delle Due Sicilie: dopo la concessione e il successivo ritiro della Costituzione da parte di Ferdinando II, la città viveva un periodo di forte repressione politica. È possibile che “Sotto altro cielo” contenesse elementi politicamente scomodi o critiche velate al regime borbonico, che Mastriani potrebbe aver deciso di autocensurare nelle edizioni successive, pubblicando una versione emendata dell’opera. Un’altra ipotesi è che il romanzo, nella sua versione originale, presentasse elementi stilistici o contenutistici che l’autore, con il maturare della sua esperienza letteraria, avrebbe poi ritenuto acerbi o inadeguati, spingendolo a modificare profondamente l’opera prima di ripubblicarla.
Le edizioni successive e la dedica alla moglie
Ciò che sappiamo con certezza è che Mastriani ripubblicò “Sotto altro cielo” in un’edizione successiva (1863), dedicandola all’amata moglie Concetta per aver sopportato insieme “i travagli d’una vita non prospera e meco si adopera alla difficile educazione de’ figliuoli“. Questa dedica offre uno squarcio sulla vita privata dell’autore, che ci fa capire come, nonostante il successo letterario, egli non godette mai di una situazione economica agiata, dovendo affrontare numerose difficoltà finanziarie e innumerevoli traslochi e cambiamenti di residenza.
- 2° ed. del 1863: i tre fascicoli con le copertine originali delle brossure
- il frontespizio del I volume
La ripubblicazione del romanzo con questa dedica suggerisce un legame emotivo particolare con quest’opera d’esordio, vista forse dall’autore come il simbolo dell’inizio del suo percorso letterario e delle sfide affrontate insieme alla moglie. Resta comunque aperto l’interrogativo su quali differenze potessero esserci tra la misteriosa prima edizione e quelle successive, e se queste differenze fossero dovute a ragioni politiche, stilistiche o personali. Il mistero di “Sotto altro cielo” rappresenta così un affascinante caso di studio per gli appassionati e gli studiosi di Mastriani, un “giallo” letterario che continua a stimolare ricerche e ipotesi.
C’è bisogno di un nuovo studio
La figura di questo grande autore del suo tempo è stata a lungo sottovalutata dalla critica ufficiale. Con la sua straordinaria prolificità e la sua capacità di raccontare la realtà sociale napoletana, Mastriani ha contribuito in modo significativo alla nascita del meridionalismo e allo sviluppo del verismo italiano. La sua narrativa, che si muove tra denuncia sociale e intrattenimento popolare, tra gotico e realismo, rappresenta un ponte tra la tradizione del romanzo d’appendice europeo e la letteratura italiana post-unitaria. La sua capacità di attrarre un vasto pubblico di lettori attraverso storie avvincenti e ricche di pathos, unita alla sua attenzione per le classi subalterne e per le problematiche sociali, ne fa un precursore di quella letteratura popolare che avrebbe conosciuto grande fortuna nei decenni successivi. C’è sicuramente da auspicarsi che qualche studioso finalmente pubblichi un riesame della sua narrativa e trovi le risposte ai quesiti irrisolti che ancora aleggiano su questo grande scrittore.
Disponibilità di alcuni dei libri citati ed altri ancora (sempre aggiornato)
Compralo su eBay